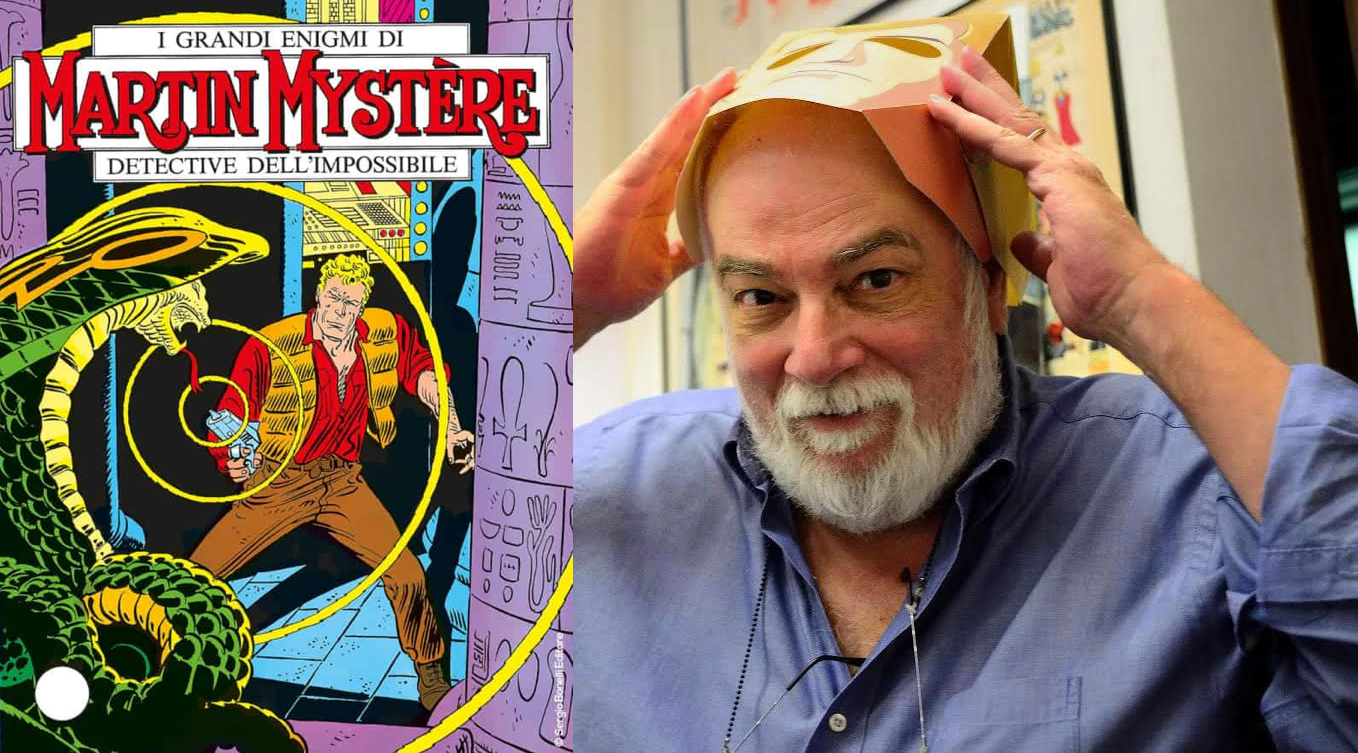Guin Saga: l’opera che ha ispirato Kentaro Miura e Berserk
Nel 1979, Kaoru Kurimoto iniziò a pubblicare Guin Saga, una monumentale serie di romanzi epic fantasy che, al momento della sua scomparsa nel 2009, contava 130 volumi. L’opera, proseguita dopo…
Leggi tutto