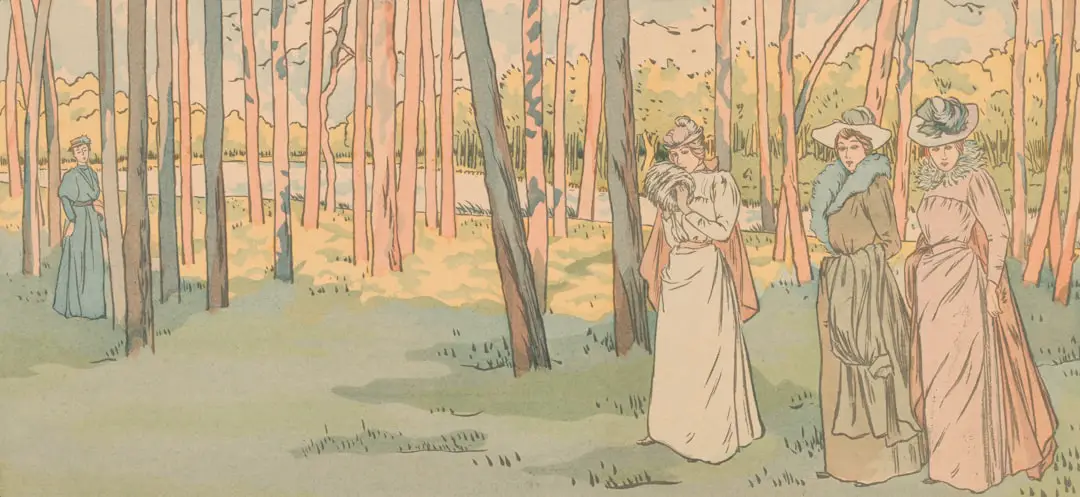Verga e ‘La Roba’, tornare a raccontare ‘veramente’ la ‘realtà’ spaventa
Per comprenderlo in ogni sfumatura bisogna leggerlo. Giovanni Verga, insieme a Luigi Capuana è considerato il padre del “verismo”, corrente letteraria che nell’800 spinse la letteratura e gli intellettuali del…
Leggi tutto